Alla metà del Settecento l’archeologia non era questo. Ma la scoperta della preistoria e delle remote origini dell’Uomo, l’espansione coloniale con l’emergere delle civiltà sepolte dell’intero pianeta, e poi l’esplosione del concetto di documento storico, l’incontro con le scienze, lo sviluppo delle archeologie dell’età medievale, moderna e perfino contemporanea, hanno provocato un ampliamento incommensurabile dei campi ma anche dei compiti dell’archeologia.
Perché qui sta il punto. Archeologia, storia dell’arte e architettura non sono discipline sorelle, tre sfere colorate appese l’una accanto all’altra sull’albero di Natale della ricerca. Lo studio della produzione artistica di un’epoca, di una regione, di una cultura è assai più vicino alla storia della letteratura o della musica: la Commedia di Dante e gli affreschi di Giotto sono prodotti artistici e letterari, come le Quattro stagioni di Vivaldi sono prodotti musicali, e in quanto espressione del loro tempo vengono studiati, rivissuti, interpretati con i metodi delle relative discipline.
L’archeologia, al contrario, non studia ‘prodotti archeologici’, semplicemente perché questi non esistono. Nulla nasce archeologico. I resti delle civiltà trascorse diventano, appunto, ‘archeologici’ solo nel momento in cui vengono sottoposti ai metodi della conoscenza archeologica, indipendentemente dalla loro natura e qualità. L’archeologia è quindi una grande scatola in cui sono virtualmente conservate le memorie materiali del passaggio dell’uomo sul pianeta: i resti del lavoro umano nella sua infinita fatica di convivere con i suoi simili e con l’ambiente che tutti ci accoglie.
Ecco allora che l’archeologia è qualcosa che – per dirla con Quintiliano 1.4.1 – plus habet in recessu quam fronte promittit, ha dentro di sé molto di più di quanto non appaia. Molto di più. Se non diradiamo le nebbie di questo secolare equivoco, rischiamo di continuare a non capirci. L’archeologia è quindi anche una forma mentale, un modo di percepire la realtà. Attraverso la sua lente guardiamo l’intreccio delle tracce nelle quali siamo immersi e il nostro vivere quotidiano acquista uno spessore più denso, le cose si animano e ci catturano trascinandoci con loro nella ‘durata’ del tempo. L’archeologia ci permette di valutare la lontananza che separa la nostra vita da quella del passato, più o meno remoto; e al tempo stesso ce ne fa percepire la vicinanza che deriva dalla frequentazione degli stessi spazi.
Questo doppio modo di percepire il passato non si limita al rapporto spazio/tempo, ma investe tanti aspetti della nostra vita di relazione, della nostra psicologia, della nostra condizione antropologica contemporanea. Abitando le nostre case ne intuiamo la struttura che sopravviverà a chi le vive e a molte delle suppellettili che le riempiono, così come dietro la pelle del nostro corpo sentiamo il nostro scheletro come la parte materiale di noi più duratura. La percezione archeologica di noi stessi ci colloca fisicamente e spiritualmente nella storia e ci invita ad affiancare ai resti materiali le tracce immateriali del ricordo. Ci invita a non perdere di vista l’importanza delle emozioni, che non significa dare spazio a un’archeologia più irrazionale, ma semmai a un’archeologia più umana, capace di praticare l’ironia, innanzitutto su se stessa. Le ‘cose’ del passato dispongono le persone in un flusso ininterrotto che conserva i frammenti di un puzzle infinito che, se fosse ricomponibile, ci restituirebbe l’immagine fantastica del nostro essere di ieri, di oggi e di domani.
Scriveva Umberto Eco una frase bellissima: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Ecco, vorrei dire che l’archeologia è lo strumento che ci permette di vivere le vite degli altri: un modo per attingere l’infinito e non morire.
La ribalta del presente sembra suggerirci che davanti a noi ci sia solo il nuovo, qualcosa che sfugge alle nostre possibilità di conoscenza. Questo salto nel futuro descrive alcuni aspetti dell’ansia contemporanea ma, se è ingenuo continuare a credere che la storia si ripeta e che sia possibile evitare, conoscendoli, gli errori del passato, è però vero che resta intatto il nostro bisogno di storia, come ricerca di una consapevolezza della stratificazione dell’esperienza umana e sociale e delle sue conseguenze, come un’infinita ricerca di noi stessi.
“Accettarsi al passato, prendere atto del fatto che la propria vita è andata finora in un certo modo – ha scritto Giovanni Jervis – è una delle condizioni per non avvelenare l’esistenza a se stessi e al prossimo”. L’uso che facciamo del nostro passato influisce sul nostro modo di pensarci, può cambiare gli effetti di ciò che è stato su ciò che è e sarà. Se questo è vero nel campo dell’esperienza personale, nella dimensione del passato collettivo ‘accettare’ la storia non significa giustificarla, ma comprenderla, e sentire il suo peso nella costruzione del futuro di tutti e di ciascuno.
Scavare nel tempo trascorso è un’operazione mentale che l’archeologia trasforma in una pratica operativa sostenuta da un’impalcatura complessa fatta di teorie, metodi e procedure, che costituiscono il bagaglio non solo professionale, ma etico di questa disciplina. La sua eticità sta nella propensione a non alzare steccati rassicuranti, ma anzi a invadere il campo: non per rubare le mele, ma per scambiare le sementi, contaminare culture ed individui, con il gusto della curiosità intellettuale e umana e il rispetto delle persone, che è tutt’altra cosa dell’ipocrita rispetto delle idee. E se l’archeologia non è mai neutra, e non può essere neutrale, la sua eticità sta nella consapevolezza professionale che non esiste ‘il pubblico’, ma che esistono tantissimi pubblici diversi, e che in realtà non esistono neppure i pubblici ma solamente le persone. Che ogni persona si porta un mondo dentro di sé quando si accosta a un’istituzione culturale, a un sito, a un museo, a un’opera d’arte, e vorrebbe allontanarsene sentendosi protagonista di uno scambio.
La sua eticità sta nella capacità di calarsi negli aspetti più grevemente materiali della realtà e al tempo stesso di guardarla da lontano nello spazio e nel tempo, per quella sua invidiabile prerogativa di poter viaggiare nell’infinitamente grande e nell’infinitamente piccolo, come solo la fisica sembra saper fare. Per quella sua affascinante capacità di sporcarsi le mani mantenendo la mente e l’anima pulite; e forse per quel vizio suo necessario di mettere il naso nei fatti altrui, nelle discipline altrui, senza negare la necessità dello specialismo, ma riconoscendo l’urgenza di una comprensione più globale e più colta del mondo in cui operiamo, di quello passato che studiamo e di quello presente per il quale studiamo, perché il fascino del passato non ha senso senza la curiosità per il moderno e il futuro.
Foto di copertina © Teodoro Teodoracopulos






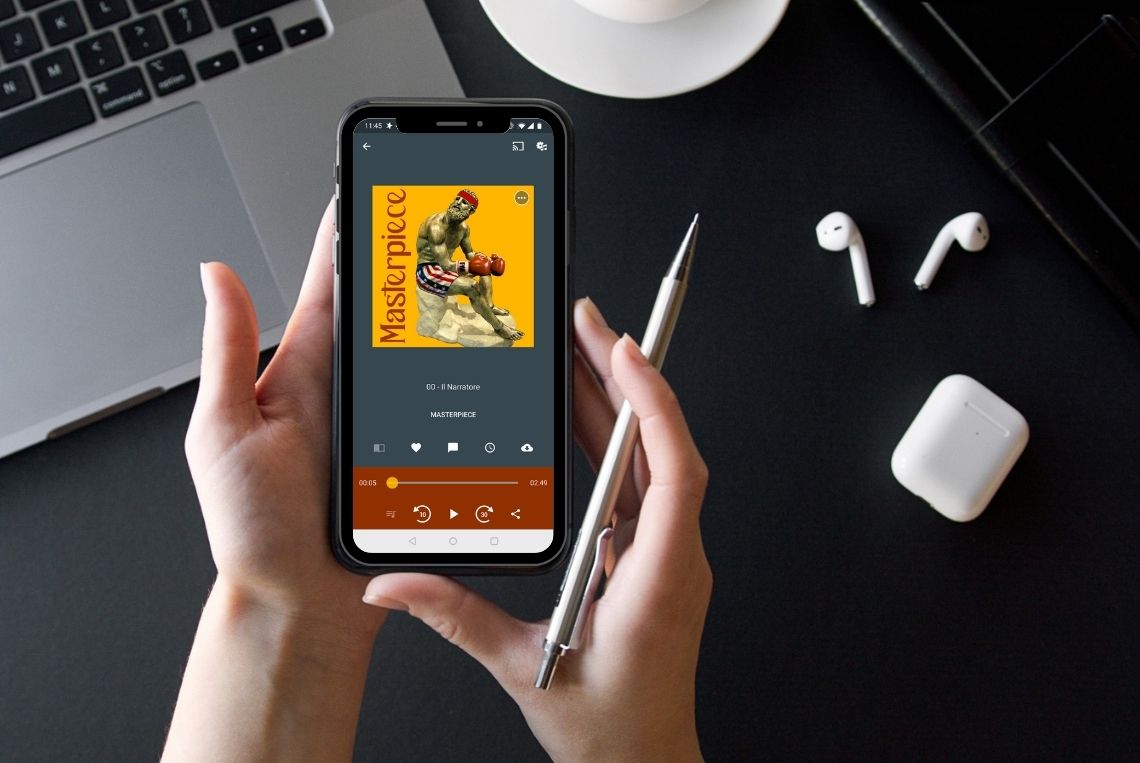


0 commenti