Stabiae, 71 d.C.
Pane al miele. Pane all’uva. Pane alle noci.
Focacce con frutta secca, panini cotti nel latte, pani al mosto, pane speziato.
Tortini caldi al formaggio, fagottini ripieni di lardo, pagnotte insaporite con una spruzzata di pepe, anice, sedano.
Difficile scegliere, pensa Marzia, aspirando a occhi chiusi il profumo inebriante che si diffonde per la strada. Lo stomaco le brontola per la fame. Non ha fatto in tempo a fare colazione prima di uscire di casa. Ieri sera, dopo i compiti, ha dovuto aiutare la mamma a consegnare ai clienti le ultime ceste di panni lavati. Così stamattina era così stanca che ha faticato ad alzarsi, e adesso è costretta a correre per non fare tardi a scuola.
Supera la panetteria e si fa largo in una ressa di donne vocianti e schiavi in fila alla fontana. Finalmente svolta nel porticato dove si tengono le lezioni. Le tracce dell’ultimo terremoto sono evidenti: gli affreschi sulla parete interna sono rovinati da una ragnatela di crepe e alcune colonne sembrano inclinate come alberi piegati dal vento. Ma il maestro è sempre al suo posto. Sta scartabellando i suoi rotoli di papiro, senza curarsi del caos di strilli, risate e chiacchiere che lo circonda.
Marzia sospira di sollievo. Si avvicina a un gruppetto di compagne che parlottano eccitate.
Calpurnia le va subito incontro e la prende a braccetto. «Hai sentito di Petronilla?» sussurra in tono di cospirazione.
«Sentito cosa?»
«È stata promessa a Quinto Lucilio Balbo!»
Marzia corruga la fronte. «E chi è?»
«Dai, i Lucilii Balbi! Quelli che vendono vino a Baia!»
C’è chi ha tutte le fortune, pensa Marzia. Di certo Petronilla non dovrà mai limitarsi ad annusare i dolci fuori dalla panetteria: nella casa del suo promesso sposo si mangerà solo pane bianco, quello impastato con la farina più fine…
Calpurnia parla sempre più in fretta, per sfruttare gli ultimi istanti prima dell’inizio della lezione. «… e si sposeranno appena lei avrà compiuto dodici anni. Peccato non aver fatto in tempo a salutarla. Guarda caso, ha lasciato la scuola proprio oggi che il maestro doveva interrogarla!»
«Cosa?» chiede Marzia, riscuotendosi dai suoi sogni di pane e farina. «Petronilla ha lasciato la scuola? Ma perché? È una delle più brave della classe!»
Calpurnia le dà una gomitata scherzosa. «Scema, ti pare che a Lucilio Balbo interessi una nuora che parla greco e recita i poemi di Livio? Tutto quello che vuole da Petronilla è un erede per la sua gens! E lei dovrà smettere di frequentare i nostri compagni per non rovinarsi la reputazione» aggiunge con una smorfia, e indica col mento Aulo, Marco e Tito che si stanno azzuffando con spade di legno, approfittando della distrazione del maestro.
Marzia tace. Osserva i ragazzi che giocano, le bambine che chiacchierano e ridono divise in gruppetti, il maestro chino sui rotoli, le capsae[1] abbandonate in giro. Annusa a pieni polmoni l’odore familiare dell’inchiostro, del cuoio, del papiro e della cera. Questo è stato il suo mondo per anni. Le fa effetto pensare che anche lei, molto presto, dovrà lasciarlo per cercarsi un lavoro. E poi un marito. E partorire i propri figli, sperando di sopravvivere all’impresa.
Per la povera Petronilla il temuto momento è già arrivato. Eppure non ha ancora compiuto dieci anni…
Ma Calpurnia segue tutt’altri ragionamenti. «Pensa» dice in tono sognante. «Dormire su un materasso imbottito di piuma, lavarsi nelle terme private, farsi servire dagli schiavi, organizzare banchetti, ricevere in casa gioiellieri, sarti e profumieri per scegliere tutto quello che si vuole… e noi restiamo qui a ricalcare lettere, contare sassolini e farci frustare dal maestro!»
«Però siamo libere di uscire senza scorta e giocare per strada» obietta Marzia.
Non aggiunge quel che sta pensando: che, in fondo, studiare la diverte. E le piacerebbe scoprire la letteratura greca e latina, la mitologia, la storia e la geografia, se potesse proseguire gli studi.
Ma non dice nulla; sa che l’amica non la capirebbe. L’unico obiettivo, per le ragazze come loro, è trovare un lavoro meno massacrante di quello dei genitori. Marzia pensa alle mani screpolate di sua madre, alle sue dita storte e gonfie, all’odore di urina che le impregna i vestiti e i capelli per quanto tenti di lavarsi e profumarsi.
Ecco, non vorrebbe proprio lavorare in una conceria, né vendere pesce al mercato come la mamma di Calpurnia. Le piacerebbe un lavoro che la tenga lontano dai cattivi odori tra cui vive da quando è nata.
Magari una bancarella di fiori. O una bottega di lozioni e creme per il corpo. O forse… una panetteria! Quello sì che è il profumo più buono di tutti!
Sta per dirlo a Calpurnia, quando improvvisamente comincia a girarle la testa. Lo stilo che ha appoggiato sullo sgabello rotola sopra la tavoletta e cade per terra, spuntandosi. Un filo di polvere si stacca dal soffitto del portico.
Scolari e passanti si immobilizzano, gli occhi sgranati. Dopo qualche istante che sembra durare ore, la vibrazione si spegne. Tutti tornano alle loro attività come se nulla fosse successo.
Marzia raccoglie lo stilo e cerca di riparare la punta. Non c’è più tempo per parlare. Il maestro ha alzato la testa, si è incupito, ha preso la canna. La fa sibilare nell’aria e tutti gli alunni corrono ai loro sgabelli, raccolgono tavolette e stili, pian piano fanno silenzio.
Marzia infila nella capsa l’involto della merenda che le ha dato la mamma. Mangerà più tardi, durante la pausa. Sa già cosa contiene il pacchetto: una fetta di pane nero. Cibo grezzo, da schiavi e poveracci. Ma per una volta non se ne vergogna.
Oggi il maestro interroga, Petronilla è assente e non c’è tempo per pensare alla setacciatura della farina.
Nella Roma antica non esisteva l’istruzione pubblica: la prima cattedra (di retorica) stipendiata dallo Stato fu istituita dall’imperatore Vespasiano nel 78 d.C.
I bambini, maschi e femmine, frequentavano lezioni private che si tenevano perlopiù all’aperto, sotto dei portici, oppure in una stanza adibita all’uso in una casa privata o in una bottega in disuso. Il maestro, spesso un liberto (cioè uno schiavo affrancato), veniva pagato direttamente dai genitori e insegnava a leggere, scrivere e contare. Gli insegnanti godevano di scarsissima considerazione, soprattutto quelli del ciclo ‘elementare’, i ludimagistri.
Chi poteva proseguire gli studi oltre i dodici anni veniva affidato a un grammaticus che insegnava letteratura greca e latina con un’infarinatura generale in mitologia, astronomia, matematica e geografia. Infine gli adolescenti di quindici-sedici anni si dedicavano allo studio della retorica sotto la guida di un rhetor.
I figli di famiglie aristocratiche e benestanti, invece, erano seguiti da un precettore personale, generalmente un colto schiavo greco.
Il terremoto di cui si parla nel racconto è quello del 62 d.C. che colpì tutta l’area vesuviana ed ebbe come epicentro proprio Stabiae. La ricostruzione dei numerosi danni e crolli non era ancora ultimata quando, nel 79 d.C., l’eruzione del Vesuvio distrusse l’area intera. E comunque a quella prima scossa ne seguirono altre, sia nei giorni che negli anni successivi. Proprio come Marzia e le sue amiche, alle lievi scosse di terremoto gli abitanti dell’area vesuviana non facevano quasi più caso.
[1] Capsa: contenitore cilindrico con coperchio, usato dagli scolari romani come l’odierna cartella o zaino.







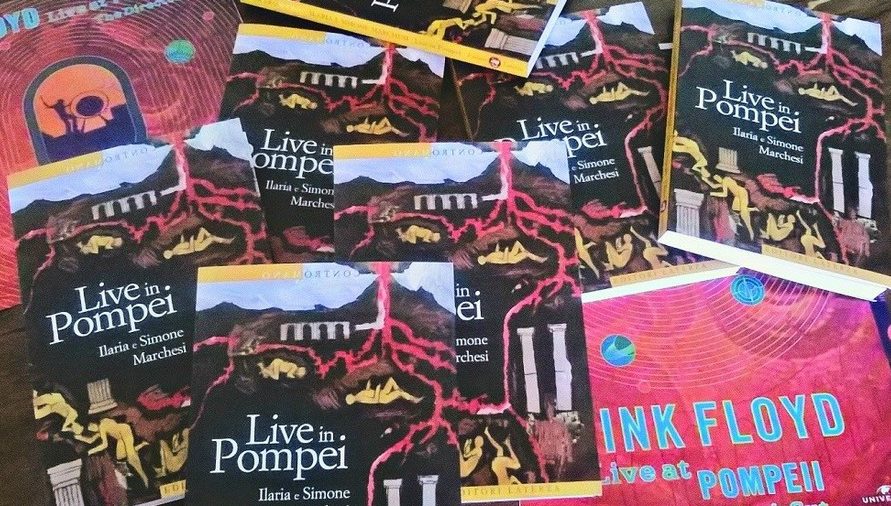

Vogliatemi bene!
Io mi domando e dico, ma ammesso che abbia senso parlare di Archeologia con l’idea di raggiungere giovani e giovanissimi/e, e questo io arrivo a crederlo sebbene non senza problematico dissidio interiore, quale dovrebbe essere il senso se non quello di provare a consolidare in loro l’unica cosa che l’Archeologia è veramente in grado di insegnare: abituarsi a pretendere che ciò che viene detto debba essere sempre passo per passo saldamente ancorato ad evidenze materiali. Abituarsi ad avere diffidenza e fastidio verso ciò che viene detto sulla base di ciò che altri hanno detto senza che si possa effettivamente riscontrare.
Se è così, e io dico che è così, stiamo facendo loro del bene o del male a raccontare storie che associano prassi e alludono a sentimenti senza nessun riguardo alle differenze di tempo e di spazio e di contesto e senza un profondo riferimento a ciò che è materialmente dimostrato?
Non occorre che io mi dilunghi su quanto sia pericoloso far passare che basti ammantare di antichità per far apparire di aver calato l’idea che si vuole proporre in una dimensione meritevole di fede e di considerazione in quanto di dignità storica.
La protagonista di un altro racconto, scritto da qualcun altro, potrebbe invece che garbatamente disincantare sul pregiudizio di genere magari con uguale metodo narrativo, ma con animo più subdolo, parlare di schiavitù come giusta punizione o di pervicace arretratezza di chi ha la pelle di un determinato colore, o di quel po’ di benessere materiale e di quell’equilibrio sociale che un potere autocratico porta.
Una sola cosa può insegnare l’Archeologia: ad abituarsi a chiedere sempre “questo da cosa lo sappiamo?”
Facciamoglielo dire!