Sparta, agosto 479 a.C.
La campagna sonnecchiava nella calura del pomeriggio. Non si vedevano contadini al lavoro, né bestie al pascolo: pecore e pastori riposavano all’ombra, al riparo dal sole feroce che suscitava riflessi accecanti dalle acque dell’Eurota. Ogni filo d’erba ingiallita sembrava tremare al frinire delle cicale: un peana ossessivo, monotono, assordante.
Quel richiamo trapassava le tempie di Eunice come un punteruolo. Si massaggiò la testa, sollevò le falde dello scialle che le proteggeva la nuca per dare sollievo al collo sudato. Ma servì a poco. Il vento era caldo e pesante come un mantello di lana.
Il cavallo procedeva a passo stanco, ciondolando la testa. Eunice non lo spronò. Non aveva fretta. I suoi contadini non si aspettavano una visita della padrona. Non quel giorno, con la città in festa per la vittoria e in lutto per i suoi caduti.
Eunice non aveva mai capito il senso di quelle celebrazioni. I morti sono morti, non possono sentire canti e preghiere o assaggiare le offerte; quegli uomini avevano svolto il loro dovere e ora riposavano in seno alla patria che li aveva partoriti. Così come era stato loro insegnato.
Si guardò intorno, stringendo gli occhi nella luce cruda. Le terre destinate a suo figlio si stendevano fino ai piedi delle montagne. Buone terre fertili, coltivate a ulivi, cereali e alberi da frutta, garanzia di un futuro di benessere e prosperità. Un futuro tranciato da un singolo affondo di lancia.
Una voce squillante si levò all’improvviso in un canto dedicato ad Artemide. Eunice trasalì, si voltò a metà sulla sella.
I servitori iloti camminavano in silenzio sul sentiero, piedi e polpacci impastati di polvere bianca. Pochi passi davanti a loro, la piccola Ermione cavalcava la sua giumenta cantando a gola spiegata. I capelli arruffati dal vento, neri e ricci come quelli del fratello, splendevano al sole.
Eunice sentì l’impulso improvviso di urlarle di tacere. Non avrebbe saputo dire perché. La bambina aveva una bella voce, di cui i genitori erano sempre andati fieri, e il tema del canto era appropriato. Aveva presenziato alla lunghissima cerimonia funebre con un comportamento impeccabile, degno della figlia del nobile Callicrate, ed era normale che sentisse il bisogno di sfogarsi un po’. In fondo aveva solo sette anni.
Sette anni, la stessa età del fratello quando aveva detto addio alla casa paterna per iniziare l’addestramento.
Eunice ricordava i due giovani robusti che erano venuti a prenderlo, muscolosi, seminudi, inespressivi. Rivedeva la palla di stoffa che cadeva dalla mano di Demarato, la paura nei suoi occhi sgranati quando si era voltato a guardarla, cercando un aiuto che lei non poteva dargli.
Eunice scosse la testa. Si sentiva male, una nausea strisciante risaliva dallo stomaco alla gola. Che si trattasse del suo ciclo di sangue mensile arrivato in anticipo?
Rimpianse di non aver portato qualche pezzuola di lino. Avrebbe voluto smontare da cavallo, bere acqua fresca e sedersi all’ombra, ma non era il caso di mostrare simili segni di debolezza davanti agli iloti.
Continuò a cavalcare, le labbra secche, il respiro sempre più affrettato. La vocina di Ermione risuonava fra i tronchi contorti degli ulivi, accompagnata dal coro delle cicale. Quel canto le entrava dentro in un turbine di vento, smuoveva sensazioni sopite, trascinava con sé ricordi sparsi come le foglie secche sul sentiero.
Risentì la propria voce tremante d’emozione mentre cantava con voce sommessa per il neonato stretto al suo petto. Era minuscolo, perfetto in ogni particolare: le mani, i piedi, il naso, le orecchie, perfino le unghie. Ricordava di avergli contato le dita minuscole una a una.
Il sollievo di scoprirlo sano, le lacrime vergognose al momento di consegnarlo alla nutrice. La prima pappa di miele e cereali sputata in faccia alla serva, con gran divertimento del padre. Le sue urla gioiose quando traballava sulle gambette inseguendo Argos, il cane di casa. La prima volta che l’aveva chiamata “madre”. Il visetto raggiante quando le serve cucinavano i suoi dolci preferiti al formaggio e miele, una leccornia concessa solo nei giorni di festa.
Eunice ansimò, con le guance in fiamme. Stava sudando tanto che le redini le scivolavano dalle mani.
“Signora?” chiamò cautamente uno dei servi.
Lei lo zittì con un gesto imperioso e si raddrizzò sulla sella. Non voleva leggere la pietà negli occhi di un ilota, vigliacco e infido per natura; le mani di quella gente erano fatte per impugnare la zappa, non le armi: mai e poi mai avrebbero capito l’orgoglio di servire Sparta, l’onore di cadere da eroi per irrorare col proprio sangue la terra natale.
I figli degli iloti erano destinati a invecchiare logorandosi nel lavoro, senza mai conoscere il canto, la danza e la guerra… mentre il suo Demarato era morto appena ventenne, forte e bello come un dio, prima che la vecchiaia potesse deturpare quello che lei stessa aveva creato…
“Mamma?” la chiamò Ermione, spaventata. “Stai male?”
Era tuo fratello, avrebbe voluto gridare Eunice. Come fai a cantare con tanta allegria? Come puoi sorridere alla luce del sole?
Ma Demarato aveva lasciato la loro casa prima della sua nascita, ricordò a se stessa; i due fratelli non erano cresciuti insieme, si conoscevano appena…
E io, io cosa sapevo di lui? Io conoscevo il bambino vivace, goloso di dolci, che sgridavo perché tirava la palla contro il muro del giardino. Non so nulla dell’uomo che era diventato.
Rivide il sorriso disarmante del piccolo Demarato, con l’incisivo scheggiato da una caduta rovinosa sulle pietre del cortile. Poi ricordò la sua ultima visita, quando lei, trovandoselo davanti sulla porta di casa, per un lungo istante non l’aveva riconosciuto.
Torace scolpito, lunghi capelli neri annodati sulla nuca, occhi vuoti che l’avevano squadrata senza tradire alcuna emozione. La metamorfosi era completa. Sparta aveva ricevuto un bambino e aveva restituito un oplita.
Quale sorriso può sopravvivere a tanti anni di fame e freddo, paura e frustate?
Chiuse gli occhi, non voleva pensarci. Suo figlio era uno Spartiate ed era nato, vissuto e morto così come la sua città gli chiedeva.
Demarato figlio di Callicrate, caduto con onore a Platea, combattendo il nemico persiano. La sorte che ogni madre avrebbe dovuto augurarsi per il proprio figlio. Motivo di vanto per la famiglia e di gloria per la città. Non c’era altro da dire.
Le donne spartane non piangono.
Cosa gli aveva detto al momento del commiato, mentre lo guardava raccogliere il grande scudo di bronzo che aveva appoggiato accanto alla porta? Quali furono le ultime parole che aveva rivolto a suo figlio?
“Torna col tuo scudo al braccio oppure disteso sopra lo scudo.”
La vittoria o la morte. Eunice tirò un lungo sospiro.
Le donne spartane non piangono.
Ma lei non era solo una donna spartana. Era una donna, era spartana, era Eunice, amministratrice accorta, danzatrice aggraziata, allevatrice di cavalli vincenti. Ed era una madre. La madre di Demarato.
Si coprì il viso con lo scialle. E pianse suo figlio sotto gli ulivi, in silenzio, protetta dalla nenia aspra delle cicale.
Sparta era famosa nel mondo greco per il valore dei suoi soldati; i bambini lasciavano le famiglie in tenera età per iniziare l’addestramento. La società era rigidamente divisa in Spartiati (cittadini a pieno titolo, ai quali veniva assegnato un lotto di terra fin dalla nascita) e Iloti (contadini e servitori ridotti in condizioni di semi-schiavitù). Infine vi erano i Perieci, coloro che vivevano nei dintorni della città, dedicandosi liberamente all’agricoltura e al commercio, ma senza godere dei diritti politici.
Le donne spartane godevano di una condizione migliore rispetto a quelle delle altre città: potevano amministrare la casa e le terre, cavalcare, gareggiare nella corsa a piedi o col carro e nella lotta… ma il loro compito principale restava quello di partorire figli sani da mandare in guerra.







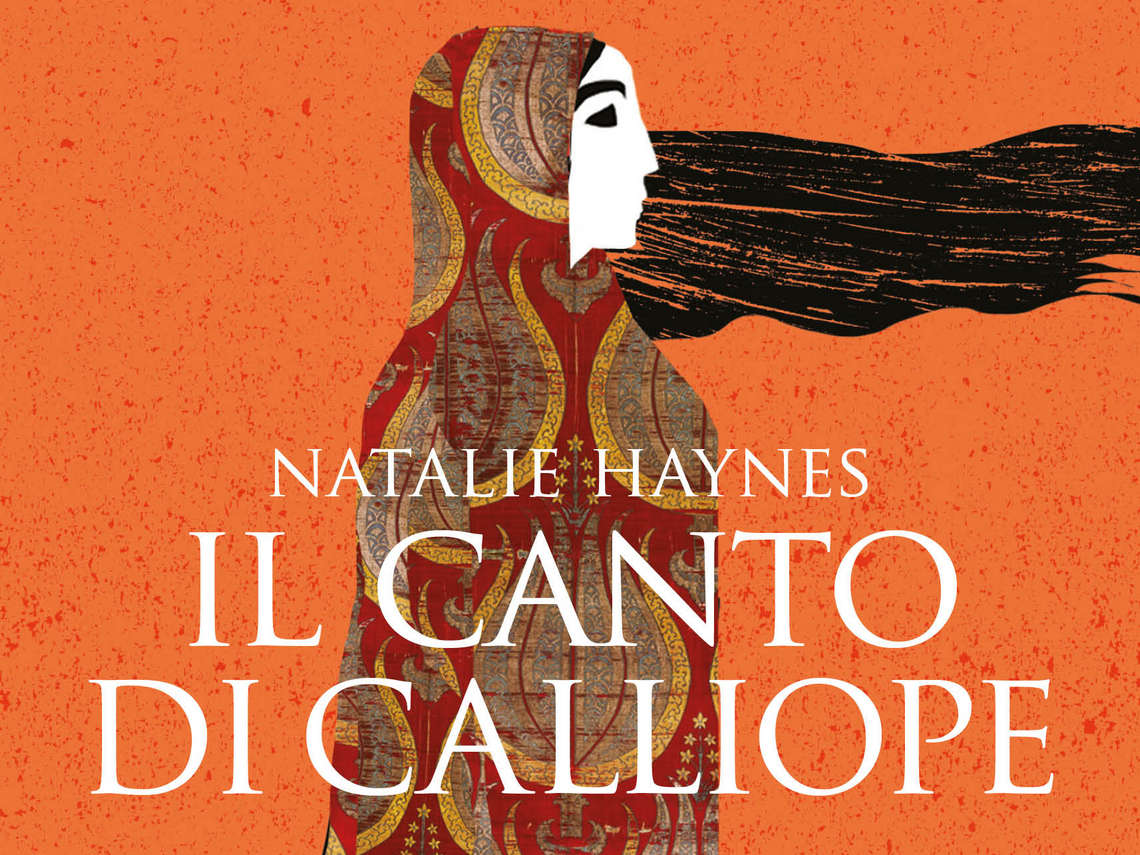

0 commenti